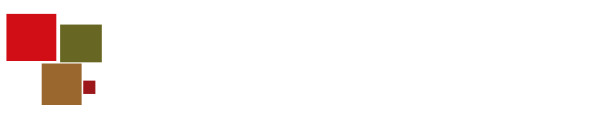È Yom Ha’Azmaut, il giorno dell’Indipendenza di Israele. La data è per tutti il 14 maggio, ma in realtà in Israele la festa cade il 5 di Iyar, ossia dell’ottavo mese del calendario ebraico, quest’anno il 20 aprile.
È Yom Ha’Azmaut, il giorno dell’Indipendenza di Israele. La data è per tutti il 14 maggio, ma in realtà in Israele la festa cade il 5 di Iyar, ossia dell’ottavo mese del calendario ebraico, quest’anno il 20 aprile.
Ieri era Yom Ha’ Zikaron, ossia il giorno in onore di tutti i caduti per Israele, il giorno dei due minuti di silenzio, un momento di raccoglimento e di serietà assoluta. Yom Ha’Azmaut invece è il momento della festa, dell’orgoglio esibito da parte di tutto il paese, del relax e del barbecue. Giorno ideale per lasciare Gerusalemme e andare verso il mare, Tel Aviv e una casa di amici vari, israeliani, canadesi, ed europei.
Per questi spostamenti interni rapidi, un’ora scarsa, la cosa migliore è prendere uno sherut, ossia un taxi collettivo. Costa meno di 5 euro parte quando si riempie (10 posti massimo), ti lascia in pieno centro cittadino, ti mostra aspetti, visi e voci di questo paese così vario.
La fermata centrale è vicino a casa, in Jaffa street. Lo sherut è già pronto ma ancora vuoto. Pago, per non dovere poi farlo a mezzo in movimento, una usanza locale, come quella di passare i soldi a chi si siede davanti che dovrà farsi carico di darli all’autista, che mentre guida e parla al cellulare darà il resto -sempre al primo della fila- che dovrò farlo arrivare al pagante iniziale. L’aria condizionata non è ancora attiva, fa troppo caldo e resti fuori all’ombra.

E lì incontro l’Africa. Un ragazzo etiope mi si avvicina e cominciamo a parlare, cosa comune in Israele, la gente ama parlare. Inizialmente penso che sia un Beta Israel, uno di quegli ebrei etiopici arrivati con le grandi ondate iniziate durante gli anni ’80 (una su tutte l’Operazione Salomone, 14.325 persone trasportate in Israele tramite un pinte aereo durato 36 ore). Ma ha una croce al collo.
Allora immagino che sia uno di quei cristiani etiopi che risiedono da sempre a Gerusalemme. Ma sono fuori strada. Benché non mi dica il suo nome, non ci siamo in realtà presentati, mi parla serenamente e a ruota libera. È arrivato poco meno di due anni fa in Israele. Ma come ti è venuto in mente di andare a lavorare in Israele? <Beh, semplicemente era l’unica via di fuga. Non era più possibile andare verso la Libia che ha stretto i controlli e allora si cambia tragitto. Ho pagato 2000 dollari, siamo stati messi su un camion con poca acqua e poco cibo, e abbiamo attraversato il Sudan, tutto l’Egitto. Mentre eravamo nel deserto ci hanno fermato delle truppe di miliziani islamici, dicevano di essere di Al-Qaeda; abbiamo dato ancora soldi, anche a loro e abbiamo proseguito. Ci sono voluti 8 giorni di viaggio. Arrivato qui ho ottenuto lo status di rifugiato politico e ora lavoro come muratore. E sono molto fortunato, perché avere un lavoro è molto difficile in questo periodo>.
Vorresti tornare in Etiopia? <Lì ho solo mia madre e mio padre, tutti i miei fratelli se ne sono andati. C’è solo povertà. Qui sto benino, posso vivere, ma non è facile. Non voglio tornare giù, aspetto il tempo per salire ancora, voglio andare in Europa, Germania, Inghilterra>.
 Lo sherut è pieno, l’autista ci chiama. Ci sediamo distanti, arrivati a Tel Aviv parte senza neanche salutarmi, è normale. Non so se mi abbia detto la verità ma è molto probabile. Bisognerebbe capire come i flussi di spostamento siano cambiati, capire gli effetti sui migranti e sulle loro decisioni e anche provare a studiare cosa sta facendo Israele, quali tensioni porterà quest’arrivo di etiopi cristiani e musulmani, quali problemi ha già creato.
Lo sherut è pieno, l’autista ci chiama. Ci sediamo distanti, arrivati a Tel Aviv parte senza neanche salutarmi, è normale. Non so se mi abbia detto la verità ma è molto probabile. Bisognerebbe capire come i flussi di spostamento siano cambiati, capire gli effetti sui migranti e sulle loro decisioni e anche provare a studiare cosa sta facendo Israele, quali tensioni porterà quest’arrivo di etiopi cristiani e musulmani, quali problemi ha già creato.
Un primo dato è evidente.
La stazione centrale di Tel Aviv, uno dei luoghi più lerci di Israele, circondata da case incerte e da caos ha già visto un cambio abitativo: se prima erano i Sefarditi (ebrei originari dei paesi arabi) a occupare questi squallidi sobborghi, ora sono proprio gli etiopi a prenderne possesso.
FILIPPO PETRUCCI, CSAS – Centro Studi Africani in Sardegna