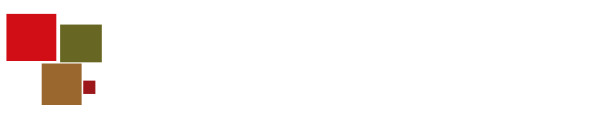Non faccio a tempo a mettere piede fuori dal portone di casa, che tutti i bambini del vicinato iniziano a vociare: Faranji!, oppure Yu!. Il primo è il termine amarico per indicare le persone di pelle bianca come me. L’etimologia di “Yu!”, invece, mi è ignota, ma ho come il sospetto che abbia a che vedere con il pronome inglese “you”, che frequentemente pronunciamo: How are you? How old are you? Do you have …? Do you know…? You, you, you…
Non faccio a tempo a mettere piede fuori dal portone di casa, che tutti i bambini del vicinato iniziano a vociare: Faranji!, oppure Yu!. Il primo è il termine amarico per indicare le persone di pelle bianca come me. L’etimologia di “Yu!”, invece, mi è ignota, ma ho come il sospetto che abbia a che vedere con il pronome inglese “you”, che frequentemente pronunciamo: How are you? How old are you? Do you have …? Do you know…? You, you, you…
Non è che sia poi una grande novità. In Mozambico mi chiamavano Mulungu!, e nei pochi giorni trascorsi a Luanda, in Angola, ero Pula! A Benguela, la cittadina angolana dove ho vissuto per diversi mesi, non c’era nemmeno un nome per me. Il fatto che una bianca se ne andasse in giro per i quartieri poveri era talmente fuori dall’ordinario da non meritare neppure la fatica di coniare una parola. In realtà penso che non credessero che fossi proprio bianca. Non era raro, infatti, sentirmi chiamare Mulata!, perché i mulatti, da quelle parti, erano numerosi: in genere figli del colono portoghese (non di rado in là con gli anni) e della giovane e affascinante collaboratrice domestica, perché il contrario (la senhora con l’aitante giardiniere) sarebbe stato uno scandalo. Anche brasileira era frequente, ed aveva un significato positivo: per ragioni storiche e linguistiche gli angolani sono molto legati ai brasiliani, li ammirano per il loro successo e subiscono il fascino delle loro telenovelas.
In alternativa, spesso mi sentivo chiamare China!, oppure con suoni come cin-ciun-lai che nelle intenzioni dei ragazzini avrebbero dovuto somigliare al cinese. Questo perché i cinesi erano, tra i non-neri, il gruppo più numeroso, e poi perché i miei capelli scuri a caschetto e l’abitudine a strizzare gli occhi (miopia, in realtà) possono trarre in inganno un occhio inesperto. Dopotutto, per molti italiani è difficile riconoscere un nigeriano da un etiope, per cui c’è poco da stupirsi che loro non riescano a notare quelle che per noi sono enormi differenze. Al mio collega, invece, non capitava mai di essere scambiato per cinese: la sua corporatura e la sua carnagione scurissima lo ponevano di diritto nel novero dei mulatti. Di quelli più scuri, ovviamente. Qualche perplessità poteva essere sollevata riguardo agli occhi color del mare del Salento. Ma con gli occhiali da sole non c’era alcun dubbio.
Insomma, tornando a noi, sono anni che mi sento rinfacciare il colore della mia pelle in tutte le salse e in tutte le lingue, cosa mi stupisce ancora? Per prima cosa, l’insistenza. Qui è peggio di qualsiasi altro paese abbia visitato in passato. Passi per i piccoli villaggi dove l’arrivo di un forestiero è di per sé un avvenimento, figurarsi se è pure faranji, femmina e con dei grossi occhiali da vista. La cosa un po’ più strana è che il fenomeno è frequentissimo anche nel centro di Addis Abeba, una capitale dove pullulano sedi di organizzazioni internazionali, ONG, imprese di ogni tipo, per non parlare dei turisti. Insomma i bianchi sono tutto fuorché merce rara.
L’altra cosa che mi infastidisce ancora è il fatto che il commento è fine a se stesso. Non mi disturba se la bottegaia chiama “faranji” per indicare che è il mio turno di essere servita, quello è solo un modo per identificarmi, innocuo come “lei che indossa una maglia verde”. Mi irrita che tutti i bambini debbano urlare in coro faranji! faranji!, da quando entro nel loro campo visivo sino a quando non giro l’angolo, e anche oltre, tanto per star sicuri. Come se fosse una sorta di obbligo sociale. Qualche volta, dopo avermi avvistata, corrono in casa ad informare i fratellini che “hey, c’è una faranji che passa, sbrigati a uscire altrimenti ti perdi lo spettacolo!”. Ma il peggio è quando sono gli adulti a farlo, in quel caso non c’è nemmeno la scusa del gioco infantile.
L’altro problema è che non ho ancora capito cosa si aspettino da me. Se li ignoro, continuano. Se li saluto cortesemente in inglese, continuano. Se li saluto nel mio amarico incerto, continuano. Se sorrido divertita, continuano. Se faccio la faccia seccata, continuano. Ogni tanto ho la tentazione di ricorrere a soluzioni “estreme”: chessò, mettermi a urlare, scoppiare a piangere, fare le facce più brutte che mi riescano, provare a camminare facendo la verticale. Ma ho paura che i bimbi piccoli possano spaventarsi, e i grandi provarci gusto. Meglio di no. Non mi rimane che cercare di abituarmi all’idea.
ANNALISA ADDIS, CSAS – Centro Studi Africani in Sardegna